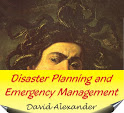"Il mio compito è di dirvi cose che non volete sentire, chiedervi di spendere denaro che non avete, per qualcosa che non credete accadrà."
Dr Ziad Abdeen, Autorità Sanitaria Palestinese
"Per la prima volta nella storia umana, abbiamo la possibilità di prepararci per una pandemia in anticipo del suo arrivo. E' quindi necessario che la comunità mondiale si dedichi subito all'azione."
Dr Margaret Chan, Direttore - Sezione Malattie Comunicabili, OMS
"Non sappiamo quando una pandemia può arrivare. Comunque, due cose sono certe: tutto ciò che faremo prima sembrerà allarmista; e tutto ciò che faremo dopo sembrerà insufficiente. Questo è il nostro dilemma, ma non dovrebbe impedirci di preparare. Dobbiamo raggiungere tutti con parole che informano e non infuocano. Dobbiamo incoraggiare tutti a preparare e non darsi al panico."
Michael Leavitt, Dipartimento Statunitense di Sanità e Servizi Umani, 2007
Come si intuisce da queste osservazioni, alcuni esperti sostengono che una nuova pandemia di influenza sia inevitabile. Se questa avviene, l'impatto potrebbe essere complesso quanto catastrofico, e per di più, non è facile preparare medicalmente, socialmente e economicamente per l'evento.
In questo saggio affronteremo quattro lati del problema: gli aspetti medici e epidemiologici; la previsione in base a modellazione e la costruzione di scenari; gi impatti sociali ed economici; e la pianificazione di emergenza.
Aspetti medici e epidemiologici
L'influenza può avvenire in tre forme. Quella stagionale è piuttosto prevedibile e si manifesta soprattutto nell'inverno. Essa può essere trasmessa da persona a persona, ma la maggior parte delle vittime hanno una certa immunità. Inoltre, è disponibile un vaccino e, tutto sommato, l'impatto sulla società è minore.
L'influenza aviaria (H5N1) è divampato nell'Asia orientale nel 2004-5. Il suo potenziale come fonte di disastro è elevata perché le persone non dispongono di immunità naturale. Al momento, un vaccino non è disponibile in commercio. Comunque, non è facile che il virus passi da uccelli ad esseri umani.
L'influenza pandemica del tipo 'A' è un nuovo virus di facile trasmissibilità tra gli esseri umani, i quali non dispongono di immunità naturale. Quindi, essa ha un'ottima propensione di provocare malattie gravi. Si divide in due tipi: Hemagglutinin (H) è composta di 16 sottotipi e agisce per attaccamento e penetrazione; Neuraminidase (NA) dispone di 9 sottotipi di 8 geni virali e cresce in assemblea per replicazione. E' bene notare che l'influenza pandemica non è uguale all'influenza stagionale, alla SARS o all'aviaria. Comunque, importanti lezioni vengono fornite da ciascuno di questi altri fenomeni.
L'influenza viene trasmessa per via respiratoria tramite gocce e aerosol prodotte quando una persona infetta parla, tossisce o starnutisce, o quando ella tocca una persona o una superficie infetta, compreso il contatto tra una mano contaminata e la propria faccia.
Le pandemie variano di gravità, e quindi lo US Federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, Georgia, autorevole istituto di studio epidemiologico, ha varato un indice della gravità della pandemia, atto ad aiutare a prevedere la gravità e progettare strategie di mitigazione. L'indice è basato sul case fatality ratio (il numero di morti per 100 casi di malattia accertati) e ha cinque categorie, come segue:
Case fatality ratio
Categoria 1: <0.1 ovvero 1 in 1000
Categoria 2: 0.1 - <0.5 ovvero 1 in 1000 - 1 in 200
Categoria 3: 0.5 - <1.0 ovvero 1 in 200 - 1 in 100
Categoria 4: 1.0 - <2.0 ovvero 1 in 100 - 2 in 100
Categoria 5: 2.0 - ovvero 2 in 100+
Inoltre la preparazione di scenari insiste su un modello delle fasi di progressione della malattia nella società.
Periodo interpandemico
Fase 1. Nessuno nuovo sottotipo di virus influenzale è stato scoperto negli esseri umani, sebbene uno può essere presente negli animali (ma con basso rischio alle persone).
Fase 2. Nessuno nuovo sottotipo di virus influenzale è stato scoperto negli esseri umani. Comunque, un sottotipo di virus circola negli animali e pone un sostanzioso rischio agli esseri umani.
Periodo di allerta di una pandemia
Fase 3. Un nuovo sottotipo sta causando infezioni nelle persone, ma senza significativa diffusione. Fase 4. La trasmissione da una persona ad un'altra è limitata e localizzata: il virus non è ben adattata agli esseri umanil
Fase 5. Avviene una maggiore trasmissione interpersonale, indicativa di un migliore adattamento del virus all'ospite umano, senza, però, la piena trasmissibilità (la fase indica un sostanzioso rischio di pandemia).
Periodo della pandemia
Fase 6. Avviene un'aumentata e sostenuta trasmissione della malattia nella popolazione generale.
Periodo post-pandemico
Si ritorna al periodo inter-pandemico, che quindi rappresenta un'occasione per lanciare ben mirate strategie di mitigazione.
Gli strumenti per combattere il rischio dell'influenza pandemica sono vaccini (che probabilmente non saranno generalmente disponibili nella prima ondata), farmaci antivirali (probabilmente di approvvigionamento limitato), interventi sulla trasmissione, misure di controllo delle infezioni, e protocolli di isolamento sociale sia di persone malate che di quelle sane.
Esistono quattro tipi di farmaco antivirale, riportati qua con i comuni nomi commerciali del prodotto in parentesi: Amatadine (Symmetrel), Rimantadine (Flumadine), Zanamivir (Relenza) e Oseltamivir (meglio conosciuto come Tamiflu). Se gli antivirali vengono presi entro 48 ore dell'inizio dell'ammaliamento, essi possono aiutare a prevenire complicazioni cliniche. Comunque, questi farmaci potrebbero non funzionare contro un virus influenzale pandemico di tipo nuovamente evoluto. In ogni caso, la loro distribuzione dovrà avvenire secondo una certa priorità premeditata e, si spera, trasparente e eticamente giustificabile. All'inizio dell'ondata di influenza gli antivirali verranno usati, molto probabilmente, per cure, anziché per profilassi.
Un'altra linea di attacco e la riduzione dell'entità delle infezioni (cioè, gli interventi sulla trasmissione della malattia). Si tratta di incoraggiare tutta la popolazione a lavarsi le mani bene e spesso con sapone, di coprire la faccia in caso di tossi e starnuti, di non sputare e, quando occorre, di portare una mascherina sulla faccia.
Infine, le tecniche di isolamento possono essere divise in due: la quarantena per persone infette, e social distancing per persone non infette, le quali, quanto possibile, si devono togliere di mezzo dalla società. In quest'ultima tattica, si tratta di aumentare lo spazio tra le persone e diminuire la frequenza di contatti sociali, con interventi mirati, soprattutto, su scuole e luoghi di lavoro.
Previsione, modellazione e scenari
Nel mondo, le pandemie di influenza sono ricorrenti tali da essere inevitabili. Esse sono ciclici con intervalli (piuttosto irregolari) di 30-40 anni. Nel passato recente gli intervalli sono stati come segue: 1847-89 (42 anni), 1889-1918 (29 anni), 1918-57 (39 anni) e 1957-68 (11 anni). Non è successa una pandemia di influenza per oltre 35 anni e quindi si suppone che una potrebbe essere imminente.
Per quanto riguarda le conseguenze, l'influenza cosiddetta "spagnola" del 1918 (H1N1; è comunque, nata in Cina) ha colpito il 25-30% della popolazione del mondo si è ammalata e l'11% di queste persone sono morti. L'impatto economico era profondo: ad esempio, negli Stati Uniti il PIL è calato del 5%. L'influenza denominata "di Hong Kong" del 1968 ha causato 34.000 morti in Asia orientale e Canada. La SARS nell'Asia orientale nel 2003 ha provocato 800 morti e un calo nel PIL di tutta la regione del 2%. Infine, l'aviaria in Asia orientale nel 2004-5 ha fatto ammalare 112 persone, di cui 57 sono morte (il 52%).
In base all'analisi di questi eventi, le previsioni per la prossima volta indica, a livello mondiale, una mortalità tra 2.0 e 7.4 milioni di persone. Le persone ricoverate in ospedale saranno almeno 135 milioni. Il PIL mondiale subirà un calo del $3.000 miliardi. Negli Stati Uniti ci sarà un aumento del 15% nella richiesta dei servizi medici, accompagnato da cali dell'80% nella domanda per servizi ricreativi e del 10% la domanda per ogni genere di prodotto.
Una simulazione elaborata per il bacino di utenza dell'Ospedale di Careggi a Firenze, utilizzando modelli parametrici generalmente accettati, indica un massimo di 5.600 degenze e 1.240 morti in un'ondata di influenza di durata 50 giorni.
In genere rispetto all'impatto sul sistema sanitario, si può ipotizzare che, malgrado le carenze del personale sanitario, di attrezzature e farmaci e dei letti nei centri medici, la domanda di servizi sanitari supererà l'offerta per molti mesi. Il vaccino sarà disponibile solo tra 6 e 8 mesi dopo l'inizio della crisi. Data la scarsa disponibilità di assistenza e l'elevatissima richiesta, la maggior parte delle degenze saranno trascorse a casa.
L'ipotizzabile scenario medico-sanitario dell'evento indica che in tutta probabilità la produzione e la distribuzione di vaccini avrà priorità su altre attività medico-sanitarie. Inoltre, per assicurare una risposta continua e sempre all'altezza della situazione, alcuni servizi privati verranno comandati o nazionalizzati dal governo.
E' bene ricordare che potrebbe verificarsi, non una sola pandemia, ma una serie di onde di malattia di durata totale fino a circa due anni. Gli impatti potranno essere divisi in quelli immediati (da giorni a settimane) e quelli a lungo termine (da settimane a mesi). A parte l'impatto prettamente medico, ci sarebbe una lunga fila di altri effetti, come viene descritto nella prossima sezione.
Impatti sociali ed economici
In sintesi, gli impatti dell'influenza pandemica possono essere divisi tra quelli medico-sanitari, quelli socio-economici e psicologici, quelli sulla politica, il governance e la pubblica amministrazione, e quelli sul mondo del commercio e degli affari.
La preparazione non può eliminare tutti gli elementi di incertezza, imprevedibilità, paura del futuro, senso di perdita, trauma psicologico, lutto, scompiglio della società e bisogno di prendere decisioni difficili. Infatti, alcuni esperti sostengono che l'impatto psicosociale possa essere molto più grande di quello fisico. Vista l'elevata probabilità di ammalarsi e addirittura morire, gli effetti psicologici non potrebbero essere altro che profondi. La paura si mescolerebbe al calo della fiducia nell'abilità delle autorità di risolvere i problemi e riportare sicurezza alla società.
Lo scenario prevede che le singole persone e le famiglie si dedicheranno ad ammassare cibo, farmaci e denaro. I più stretti rapporti sociali verranno potenziati, ad esempio tra parenti, ma quelli meno importanti verranno trascurati. Per quanto riguarda i rapporti più stretti in assoluto, ci sarà un calo della natalità che durerà tutto il periodo della pandemia ed oltre. Nello stesso tempo, per quanto riguarda la comunità, avverrà l'annullamento di molti raduni di massa, accompagnato da una dispersione della popolazione lontano dai centri urbani, un fenomeno che richiama il Decameron di Boccaccio e l'ombra delle pesti del medioevo. Sotto queste circostanze sarà difficile risolvere il problema di come fornire servizi a gruppi di persone particolarmente vulnerabili, come gli handicappati e gli anziani.
I servizi di base (come erogazione di acqua, elettricità e gas, telecomunicazioni, approvvigionamento di cibo e carburante, raccolta dei rifiuti) saranno afflitti da assenteismo e frequenti interruzioni. Inoltre, le persone che continuano a lavorare potrebbero essere portatori e diffusori di infezione. Per evitare questo, le scuole e gli atenei, ad esempio, verranno chiusi per lunghi periodi, dando agli allievi problemi di continuità dello studio. Per via dell'assenteismo e dell'allentamento generale del commercio, tutte le grandi distribuzioni saranno in calo.
A causa della vasta espansione avvenuta nelle dipendenze internazionali, la globalizzazione aumenterà sia il rischio di trasmissione che gli effetti della pandemia. Per restringere la migrazione del vettore pandemico, le frontiere, gli aeroporti e le stazioni verranno chiusi al pubblico per lunghi periodi.
Riguardo prodotti e servizi, l'assenteismo verrà accompagnato da un abbassamento della produttività che darà luogo a, tra altro, una carenza di inventario nelle fabbriche e lo scompiglio delle catene di rifornimento. Di conseguenza, ci sarà un calo della qualità e della disponibilità di prodotti e quindi un razionamento del cibo e di vari altri prodotti essenziali.
Come nell'industria, l'agricoltura subirà un calo nella produzione e nella distribuzione dei suoi prodotti. Se la trasmissione della malattia interesse gli animali, ci sarà un grande abbattimento di polli, e forse di altri tipi di bestiame. Come risultato di tutto questo, si verificheranno grandissimi aumenti nel costo dei prodotti alimentari.
Insieme al calo nella produzione, per motivi sanitari, economici e sociali, ci sarà un calo della domanda per prodotti e servizi. Questo è stato stimato dell'entità di 10% in genere e fino all'80% per servizi come il turismo, l'aviazione e la ristorazione. In compenso, ci sarà un massiccio aumento della domanda per pubblica sicurezza, servizi di evacuazione, e assistenza medica con associati servizi di trasporto.
Per quanto riguarda il governance, ci sarà una riduzione del numero di riunioni amministrative e politiche, con appositi rallentamenti dei processi decisionali. Contemporaneamente ci saranno aumenti della domanda di legislazione e sicurezza, con altrettanto grandi aumenti delle spese pubbliche su sanità, sicurezza, welfare e il sostegno delle imprese, contrastati da forti abbassamenti della spesa su funzioni non direttamente implicate nella crisi.
Nel settore finanziario, si prevede un abbassamento delle entrate fiscali per calo dell'economia. Con alta domanda per la liquidità, si aspetta un notevole aumento nell'approvvigionamento del denaro e un marcato abbassamento nel valore della moneta nazionale. La circolazione del denaro sarà abbassata, come sarà anche il valore delle azioni e quindi le quotazioni in borsa.
La crisi verrà segnata da massicci aumenti nei pagamenti assicurativi accompagnati dal fallimento di alcune compagnie assicurative. Grossi problemi sanitari accadranno nelle prigioni e ci sarà un calo nell'attività dei tribunali e dei servizi legali, quindi dell'efficienza del sistema di giustizia. Infine, nel campo dell'informazione, per paura di contaminazione non si leggerà più giornali e riviste di carta, che verranno sostituiti da mezzi elettronici. Comunque, il pubblico rimarrà intensamente interessato nelle notizie, sebbene dato il previsto calo nella produzione e nella circolazione dei giornali di ogni tipo, sarà difficile mantenere la qualità e l'accuratezza del giornalismo.
Pianificazione di emergenza
Il problema della pandemia è considerato così grave e pressante che in alcune parti dell'Europa del nord, i pianificatori stanno dedicando fino a tre quarti delle loro attività a preparare per un tale evento. La pianificazione di emergenza deve considerare alcuni aspetti particolari, tra quali:
- il massiccio aumento della domanda per servizi e prodotti sanitari
- il bisogno di etica e trasparenza delle decisioni prese
- la reazione del pubblico al rischio, all'evento e alla risposta delle autorità
- l'educazione, la formazione e l'informazione sulla crisi per tutti i settori della società
- la chiusura di scuole, imprese, negozi e luoghi pubblici
- la carenze di comunicazioni, elettricità, gas, acqua, smaltimento dei rifiuti, servizio telefonico, distribuzione del carburante, produzione e distribuzione del cibo
- la sicurezza e l'ordine pubblico
- la quarantena e l'imposizione di restrizioni sul movimento della popolazione
- come comunicare con il pubblico e i mass media.
Gli obiettivi che un pianificatore che si interesse in questo settore deve tenere in mente sono quattro: come limitare il numero di malati e morti, come mantenere la continuità dei servizi di base, come minimizzare lo scompiglio della società e le perdite economiche, e come potenziare gli appositi servizi medico-sanitari.
Le strategie possono essere riassunte nelle cosiddette "tre 'P'": persone, piani, prodotti e pratiche. Servono piani di emergenza pandemica a tutti i livelli della pubblica amministrazione e in altri luoghi, quali fabbriche, università, uffici. E' necessario creare un sistema integrato di monitoraggio e controlli medico-sanitari. Bisogna maturare una capacità di darsi ad azioni decisive e efficaci, distinte da trasparenza e buona comunicazione e dall'ampio coinvolgimento di tutti i settori del pubblico.
Conclusioni
Mentre la probabilità di trovarsi alle prese con una pandemia potrebbe sembrare assai remota a molti pianificatori di emergenza, non è affatto così improbabile. Se dovesse accadere come descritto in questo articolo, le conseguenze potrebbero essere molto profonde e l'intero "paesaggio del rischio", e quindi il panorama della protezione civile, subirebbe un cambio netto in pochissimo tempo. Le priorità verrebbero bruscamente riassettate.
Salterebbero fuori alcune questioni scottanti legate all'etica delle scelte prese, e la disponibilità e i costi di rimedi ai problemi verificati. In questo contesto, la sanità pubblica è un "potere di ordine pubblico", ovvero di polizia. In questa forma, essa potrebbe infrangere la libertà dell'individuo, ma nello stesso tempo sarà necessario difendere i diritti dei pochi mentre si cerca di proteggere l'incolumità di tutti. Sono scelte assai difficile ma è bene cominciare a studiarle subito, in "tempi di pace", anziché dover affrontare tutto per la prima volta all'altezza della crisi.
Ringraziamenti
Ringrazio Prof. Ziad Abdeen di Al Quds University, Palestina, e dott. William Hancock di Texas A & M University per i loro preziosi appunti, sui quali questo saggio è basato.
Dr Ziad Abdeen, Autorità Sanitaria Palestinese
"Per la prima volta nella storia umana, abbiamo la possibilità di prepararci per una pandemia in anticipo del suo arrivo. E' quindi necessario che la comunità mondiale si dedichi subito all'azione."
Dr Margaret Chan, Direttore - Sezione Malattie Comunicabili, OMS
"Non sappiamo quando una pandemia può arrivare. Comunque, due cose sono certe: tutto ciò che faremo prima sembrerà allarmista; e tutto ciò che faremo dopo sembrerà insufficiente. Questo è il nostro dilemma, ma non dovrebbe impedirci di preparare. Dobbiamo raggiungere tutti con parole che informano e non infuocano. Dobbiamo incoraggiare tutti a preparare e non darsi al panico."
Michael Leavitt, Dipartimento Statunitense di Sanità e Servizi Umani, 2007
Come si intuisce da queste osservazioni, alcuni esperti sostengono che una nuova pandemia di influenza sia inevitabile. Se questa avviene, l'impatto potrebbe essere complesso quanto catastrofico, e per di più, non è facile preparare medicalmente, socialmente e economicamente per l'evento.
In questo saggio affronteremo quattro lati del problema: gli aspetti medici e epidemiologici; la previsione in base a modellazione e la costruzione di scenari; gi impatti sociali ed economici; e la pianificazione di emergenza.
Aspetti medici e epidemiologici
L'influenza può avvenire in tre forme. Quella stagionale è piuttosto prevedibile e si manifesta soprattutto nell'inverno. Essa può essere trasmessa da persona a persona, ma la maggior parte delle vittime hanno una certa immunità. Inoltre, è disponibile un vaccino e, tutto sommato, l'impatto sulla società è minore.
L'influenza aviaria (H5N1) è divampato nell'Asia orientale nel 2004-5. Il suo potenziale come fonte di disastro è elevata perché le persone non dispongono di immunità naturale. Al momento, un vaccino non è disponibile in commercio. Comunque, non è facile che il virus passi da uccelli ad esseri umani.
L'influenza pandemica del tipo 'A' è un nuovo virus di facile trasmissibilità tra gli esseri umani, i quali non dispongono di immunità naturale. Quindi, essa ha un'ottima propensione di provocare malattie gravi. Si divide in due tipi: Hemagglutinin (H) è composta di 16 sottotipi e agisce per attaccamento e penetrazione; Neuraminidase (NA) dispone di 9 sottotipi di 8 geni virali e cresce in assemblea per replicazione. E' bene notare che l'influenza pandemica non è uguale all'influenza stagionale, alla SARS o all'aviaria. Comunque, importanti lezioni vengono fornite da ciascuno di questi altri fenomeni.
L'influenza viene trasmessa per via respiratoria tramite gocce e aerosol prodotte quando una persona infetta parla, tossisce o starnutisce, o quando ella tocca una persona o una superficie infetta, compreso il contatto tra una mano contaminata e la propria faccia.
Le pandemie variano di gravità, e quindi lo US Federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, Georgia, autorevole istituto di studio epidemiologico, ha varato un indice della gravità della pandemia, atto ad aiutare a prevedere la gravità e progettare strategie di mitigazione. L'indice è basato sul case fatality ratio (il numero di morti per 100 casi di malattia accertati) e ha cinque categorie, come segue:
Case fatality ratio
Categoria 1: <0.1 ovvero 1 in 1000
Categoria 2: 0.1 - <0.5 ovvero 1 in 1000 - 1 in 200
Categoria 3: 0.5 - <1.0 ovvero 1 in 200 - 1 in 100
Categoria 4: 1.0 - <2.0 ovvero 1 in 100 - 2 in 100
Categoria 5: 2.0 - ovvero 2 in 100+
Inoltre la preparazione di scenari insiste su un modello delle fasi di progressione della malattia nella società.
Periodo interpandemico
Fase 1. Nessuno nuovo sottotipo di virus influenzale è stato scoperto negli esseri umani, sebbene uno può essere presente negli animali (ma con basso rischio alle persone).
Fase 2. Nessuno nuovo sottotipo di virus influenzale è stato scoperto negli esseri umani. Comunque, un sottotipo di virus circola negli animali e pone un sostanzioso rischio agli esseri umani.
Periodo di allerta di una pandemia
Fase 3. Un nuovo sottotipo sta causando infezioni nelle persone, ma senza significativa diffusione. Fase 4. La trasmissione da una persona ad un'altra è limitata e localizzata: il virus non è ben adattata agli esseri umanil
Fase 5. Avviene una maggiore trasmissione interpersonale, indicativa di un migliore adattamento del virus all'ospite umano, senza, però, la piena trasmissibilità (la fase indica un sostanzioso rischio di pandemia).
Periodo della pandemia
Fase 6. Avviene un'aumentata e sostenuta trasmissione della malattia nella popolazione generale.
Periodo post-pandemico
Si ritorna al periodo inter-pandemico, che quindi rappresenta un'occasione per lanciare ben mirate strategie di mitigazione.
Gli strumenti per combattere il rischio dell'influenza pandemica sono vaccini (che probabilmente non saranno generalmente disponibili nella prima ondata), farmaci antivirali (probabilmente di approvvigionamento limitato), interventi sulla trasmissione, misure di controllo delle infezioni, e protocolli di isolamento sociale sia di persone malate che di quelle sane.
Esistono quattro tipi di farmaco antivirale, riportati qua con i comuni nomi commerciali del prodotto in parentesi: Amatadine (Symmetrel), Rimantadine (Flumadine), Zanamivir (Relenza) e Oseltamivir (meglio conosciuto come Tamiflu). Se gli antivirali vengono presi entro 48 ore dell'inizio dell'ammaliamento, essi possono aiutare a prevenire complicazioni cliniche. Comunque, questi farmaci potrebbero non funzionare contro un virus influenzale pandemico di tipo nuovamente evoluto. In ogni caso, la loro distribuzione dovrà avvenire secondo una certa priorità premeditata e, si spera, trasparente e eticamente giustificabile. All'inizio dell'ondata di influenza gli antivirali verranno usati, molto probabilmente, per cure, anziché per profilassi.
Un'altra linea di attacco e la riduzione dell'entità delle infezioni (cioè, gli interventi sulla trasmissione della malattia). Si tratta di incoraggiare tutta la popolazione a lavarsi le mani bene e spesso con sapone, di coprire la faccia in caso di tossi e starnuti, di non sputare e, quando occorre, di portare una mascherina sulla faccia.
Infine, le tecniche di isolamento possono essere divise in due: la quarantena per persone infette, e social distancing per persone non infette, le quali, quanto possibile, si devono togliere di mezzo dalla società. In quest'ultima tattica, si tratta di aumentare lo spazio tra le persone e diminuire la frequenza di contatti sociali, con interventi mirati, soprattutto, su scuole e luoghi di lavoro.
Previsione, modellazione e scenari
Nel mondo, le pandemie di influenza sono ricorrenti tali da essere inevitabili. Esse sono ciclici con intervalli (piuttosto irregolari) di 30-40 anni. Nel passato recente gli intervalli sono stati come segue: 1847-89 (42 anni), 1889-1918 (29 anni), 1918-57 (39 anni) e 1957-68 (11 anni). Non è successa una pandemia di influenza per oltre 35 anni e quindi si suppone che una potrebbe essere imminente.
Per quanto riguarda le conseguenze, l'influenza cosiddetta "spagnola" del 1918 (H1N1; è comunque, nata in Cina) ha colpito il 25-30% della popolazione del mondo si è ammalata e l'11% di queste persone sono morti. L'impatto economico era profondo: ad esempio, negli Stati Uniti il PIL è calato del 5%. L'influenza denominata "di Hong Kong" del 1968 ha causato 34.000 morti in Asia orientale e Canada. La SARS nell'Asia orientale nel 2003 ha provocato 800 morti e un calo nel PIL di tutta la regione del 2%. Infine, l'aviaria in Asia orientale nel 2004-5 ha fatto ammalare 112 persone, di cui 57 sono morte (il 52%).
In base all'analisi di questi eventi, le previsioni per la prossima volta indica, a livello mondiale, una mortalità tra 2.0 e 7.4 milioni di persone. Le persone ricoverate in ospedale saranno almeno 135 milioni. Il PIL mondiale subirà un calo del $3.000 miliardi. Negli Stati Uniti ci sarà un aumento del 15% nella richiesta dei servizi medici, accompagnato da cali dell'80% nella domanda per servizi ricreativi e del 10% la domanda per ogni genere di prodotto.
Una simulazione elaborata per il bacino di utenza dell'Ospedale di Careggi a Firenze, utilizzando modelli parametrici generalmente accettati, indica un massimo di 5.600 degenze e 1.240 morti in un'ondata di influenza di durata 50 giorni.
In genere rispetto all'impatto sul sistema sanitario, si può ipotizzare che, malgrado le carenze del personale sanitario, di attrezzature e farmaci e dei letti nei centri medici, la domanda di servizi sanitari supererà l'offerta per molti mesi. Il vaccino sarà disponibile solo tra 6 e 8 mesi dopo l'inizio della crisi. Data la scarsa disponibilità di assistenza e l'elevatissima richiesta, la maggior parte delle degenze saranno trascorse a casa.
L'ipotizzabile scenario medico-sanitario dell'evento indica che in tutta probabilità la produzione e la distribuzione di vaccini avrà priorità su altre attività medico-sanitarie. Inoltre, per assicurare una risposta continua e sempre all'altezza della situazione, alcuni servizi privati verranno comandati o nazionalizzati dal governo.
E' bene ricordare che potrebbe verificarsi, non una sola pandemia, ma una serie di onde di malattia di durata totale fino a circa due anni. Gli impatti potranno essere divisi in quelli immediati (da giorni a settimane) e quelli a lungo termine (da settimane a mesi). A parte l'impatto prettamente medico, ci sarebbe una lunga fila di altri effetti, come viene descritto nella prossima sezione.
Impatti sociali ed economici
In sintesi, gli impatti dell'influenza pandemica possono essere divisi tra quelli medico-sanitari, quelli socio-economici e psicologici, quelli sulla politica, il governance e la pubblica amministrazione, e quelli sul mondo del commercio e degli affari.
La preparazione non può eliminare tutti gli elementi di incertezza, imprevedibilità, paura del futuro, senso di perdita, trauma psicologico, lutto, scompiglio della società e bisogno di prendere decisioni difficili. Infatti, alcuni esperti sostengono che l'impatto psicosociale possa essere molto più grande di quello fisico. Vista l'elevata probabilità di ammalarsi e addirittura morire, gli effetti psicologici non potrebbero essere altro che profondi. La paura si mescolerebbe al calo della fiducia nell'abilità delle autorità di risolvere i problemi e riportare sicurezza alla società.
Lo scenario prevede che le singole persone e le famiglie si dedicheranno ad ammassare cibo, farmaci e denaro. I più stretti rapporti sociali verranno potenziati, ad esempio tra parenti, ma quelli meno importanti verranno trascurati. Per quanto riguarda i rapporti più stretti in assoluto, ci sarà un calo della natalità che durerà tutto il periodo della pandemia ed oltre. Nello stesso tempo, per quanto riguarda la comunità, avverrà l'annullamento di molti raduni di massa, accompagnato da una dispersione della popolazione lontano dai centri urbani, un fenomeno che richiama il Decameron di Boccaccio e l'ombra delle pesti del medioevo. Sotto queste circostanze sarà difficile risolvere il problema di come fornire servizi a gruppi di persone particolarmente vulnerabili, come gli handicappati e gli anziani.
I servizi di base (come erogazione di acqua, elettricità e gas, telecomunicazioni, approvvigionamento di cibo e carburante, raccolta dei rifiuti) saranno afflitti da assenteismo e frequenti interruzioni. Inoltre, le persone che continuano a lavorare potrebbero essere portatori e diffusori di infezione. Per evitare questo, le scuole e gli atenei, ad esempio, verranno chiusi per lunghi periodi, dando agli allievi problemi di continuità dello studio. Per via dell'assenteismo e dell'allentamento generale del commercio, tutte le grandi distribuzioni saranno in calo.
A causa della vasta espansione avvenuta nelle dipendenze internazionali, la globalizzazione aumenterà sia il rischio di trasmissione che gli effetti della pandemia. Per restringere la migrazione del vettore pandemico, le frontiere, gli aeroporti e le stazioni verranno chiusi al pubblico per lunghi periodi.
Riguardo prodotti e servizi, l'assenteismo verrà accompagnato da un abbassamento della produttività che darà luogo a, tra altro, una carenza di inventario nelle fabbriche e lo scompiglio delle catene di rifornimento. Di conseguenza, ci sarà un calo della qualità e della disponibilità di prodotti e quindi un razionamento del cibo e di vari altri prodotti essenziali.
Come nell'industria, l'agricoltura subirà un calo nella produzione e nella distribuzione dei suoi prodotti. Se la trasmissione della malattia interesse gli animali, ci sarà un grande abbattimento di polli, e forse di altri tipi di bestiame. Come risultato di tutto questo, si verificheranno grandissimi aumenti nel costo dei prodotti alimentari.
Insieme al calo nella produzione, per motivi sanitari, economici e sociali, ci sarà un calo della domanda per prodotti e servizi. Questo è stato stimato dell'entità di 10% in genere e fino all'80% per servizi come il turismo, l'aviazione e la ristorazione. In compenso, ci sarà un massiccio aumento della domanda per pubblica sicurezza, servizi di evacuazione, e assistenza medica con associati servizi di trasporto.
Per quanto riguarda il governance, ci sarà una riduzione del numero di riunioni amministrative e politiche, con appositi rallentamenti dei processi decisionali. Contemporaneamente ci saranno aumenti della domanda di legislazione e sicurezza, con altrettanto grandi aumenti delle spese pubbliche su sanità, sicurezza, welfare e il sostegno delle imprese, contrastati da forti abbassamenti della spesa su funzioni non direttamente implicate nella crisi.
Nel settore finanziario, si prevede un abbassamento delle entrate fiscali per calo dell'economia. Con alta domanda per la liquidità, si aspetta un notevole aumento nell'approvvigionamento del denaro e un marcato abbassamento nel valore della moneta nazionale. La circolazione del denaro sarà abbassata, come sarà anche il valore delle azioni e quindi le quotazioni in borsa.
La crisi verrà segnata da massicci aumenti nei pagamenti assicurativi accompagnati dal fallimento di alcune compagnie assicurative. Grossi problemi sanitari accadranno nelle prigioni e ci sarà un calo nell'attività dei tribunali e dei servizi legali, quindi dell'efficienza del sistema di giustizia. Infine, nel campo dell'informazione, per paura di contaminazione non si leggerà più giornali e riviste di carta, che verranno sostituiti da mezzi elettronici. Comunque, il pubblico rimarrà intensamente interessato nelle notizie, sebbene dato il previsto calo nella produzione e nella circolazione dei giornali di ogni tipo, sarà difficile mantenere la qualità e l'accuratezza del giornalismo.
Pianificazione di emergenza
Il problema della pandemia è considerato così grave e pressante che in alcune parti dell'Europa del nord, i pianificatori stanno dedicando fino a tre quarti delle loro attività a preparare per un tale evento. La pianificazione di emergenza deve considerare alcuni aspetti particolari, tra quali:
- il massiccio aumento della domanda per servizi e prodotti sanitari
- il bisogno di etica e trasparenza delle decisioni prese
- la reazione del pubblico al rischio, all'evento e alla risposta delle autorità
- l'educazione, la formazione e l'informazione sulla crisi per tutti i settori della società
- la chiusura di scuole, imprese, negozi e luoghi pubblici
- la carenze di comunicazioni, elettricità, gas, acqua, smaltimento dei rifiuti, servizio telefonico, distribuzione del carburante, produzione e distribuzione del cibo
- la sicurezza e l'ordine pubblico
- la quarantena e l'imposizione di restrizioni sul movimento della popolazione
- come comunicare con il pubblico e i mass media.
Gli obiettivi che un pianificatore che si interesse in questo settore deve tenere in mente sono quattro: come limitare il numero di malati e morti, come mantenere la continuità dei servizi di base, come minimizzare lo scompiglio della società e le perdite economiche, e come potenziare gli appositi servizi medico-sanitari.
Le strategie possono essere riassunte nelle cosiddette "tre 'P'": persone, piani, prodotti e pratiche. Servono piani di emergenza pandemica a tutti i livelli della pubblica amministrazione e in altri luoghi, quali fabbriche, università, uffici. E' necessario creare un sistema integrato di monitoraggio e controlli medico-sanitari. Bisogna maturare una capacità di darsi ad azioni decisive e efficaci, distinte da trasparenza e buona comunicazione e dall'ampio coinvolgimento di tutti i settori del pubblico.
Conclusioni
Mentre la probabilità di trovarsi alle prese con una pandemia potrebbe sembrare assai remota a molti pianificatori di emergenza, non è affatto così improbabile. Se dovesse accadere come descritto in questo articolo, le conseguenze potrebbero essere molto profonde e l'intero "paesaggio del rischio", e quindi il panorama della protezione civile, subirebbe un cambio netto in pochissimo tempo. Le priorità verrebbero bruscamente riassettate.
Salterebbero fuori alcune questioni scottanti legate all'etica delle scelte prese, e la disponibilità e i costi di rimedi ai problemi verificati. In questo contesto, la sanità pubblica è un "potere di ordine pubblico", ovvero di polizia. In questa forma, essa potrebbe infrangere la libertà dell'individuo, ma nello stesso tempo sarà necessario difendere i diritti dei pochi mentre si cerca di proteggere l'incolumità di tutti. Sono scelte assai difficile ma è bene cominciare a studiarle subito, in "tempi di pace", anziché dover affrontare tutto per la prima volta all'altezza della crisi.
Ringraziamenti
Ringrazio Prof. Ziad Abdeen di Al Quds University, Palestina, e dott. William Hancock di Texas A & M University per i loro preziosi appunti, sui quali questo saggio è basato.