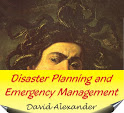In Kashmir nel 2005 10.000 scuole sono state distrutte dal sisma, 17.000 bambini e ragazzi sono morti sotto le macerie ed altri 30.000 bambini hanno perso le proprie scuole. Mentre è assai improbabile che si manifesti una situazione del genere in Italia, il terremoto del Kashmir ha stimolato, non soltanto il fiume della solidarietà italiana, ma anche un aumento del senso di paura riguardo la vulnerabilità sismica delle scuole italiane, specialmente nell'ottica del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia. In Italia, circa 6,6 milioni di bambini e ragazzi frequentano 60.000 scuole. Molti degli edifici sono ubicati in zone sismiche e i fondi per renderli tutti resistenti al sisma sono insufficienti. Questa situazione costituisce un dilemma difficile dal punto di essere angosciante rispetto a quali scuole scegliere per l'adeguamento sismico urgente e quali non includere nei programmi. C'è, inoltre, una mancanza di dibattito pubblico, probabilmente per paura delle conseguenze quando i genitori si rendono conto che i loro figli frequentano scuole che non sono state adeguate al rischio.
Quest'anno alcuni studiosi e professionisti hanno fondato un gruppo internazionale intitolato COGSS - Coalition for Global School Safety (Coalizione Globale per la Sicurezza delle Scuole). L'iniziativa parte dal principio che i bambini e i ragazzi abbiano un diritto morale, non soltanto a ricevere un'educazione scolastica, ma ad averla in condizioni di sicurezza. COGSS lotterà per convincere i governi di tutti i paesi del mondo a rispettare questo principio. Il suo sito web, di taglio multinazionale e multilingue, è sotto costruzione a www.interragate.info/cogss/index.html.
L'obiettivo di COGSS è di fornire gli strumenti per approfitare dalle esperienze positive e dai best practice dovunque che si riesca ad identificare qualcosa che vale la pena condividere. Nella protezione civile non seguiamo questa linea quanto potremmo. Ad esempio, uno dei documenti più interessanti e di maggiore rilievo pubblicato durante quest'anno è il rapporto sulle bombe londinesi del 7 luglio 2005 compilato da una commissione di deputati della London Assembly, il "parlamento" della città di Londra (vedi www.london.gov.uk/assembly/reports/general.jsp). Gli autori di questo rapporto non hanno soltanto ricostruito in parole la dinamica di quella tremenda giornata e della risposta di emergenza agli eventi, ma hanno anche raccolto i punti di vista di una larga gamma di esponenti della protezione civile, di vittime e superstiti dei quattro oltraggi terroristici, di londinesi qualunque, e di molti altri soggetti.
Alcune della conclusioni del rapporto sono ben conosciute da tempo, ad esempio sul bisogno di migliorare la cooperazione in situazioni di emergenza tra organizzazioni che normalmente non lavorano insieme, o per lo meno non collaborano nello stesso modo in assenza di una crisi. Altre conclusioni dovrebbero essere ripetute più spesso, ad esempio sul bisogno di rinforzare i canali di comunicazione durante le grandi emergenze. Le reti di telefonia cellulare possono entrare in avaria (a Londra hanno subito raggiunto la saturazione), le frequenze radio potrebbero essere incompatibili, e le radio potrebbero non funzionare in ambienti sotterranei o elevati. Ma la Commissione ha trovato che i più pressanti problemi di comunicazione erano quelli riguardo la presa e la diffusione delle decisioni. E' necessario dare enfasi al fatto che in uno stato di emergenza bisogna dare ordini chiari ed espliciti alle persone giuste al momento giusto, bisogna condividere le decisioni tra le organizzazioni partecipanti, e bisogna informare i protagonisti della protezione civile di che cosa fanno, e che cosa non fanno, gli altri protagonisti delle operazioni di emergenza.
La conclusione più interessante della Commissione dell'Assemblea Londinese è che la protezione civile ha bisogna di uno sostanzioso riorientamento. Finora si è occupato preferenzialmente dell'allestimento e del perfezionamento di organizzazioni, procedure e protocolli, un orientamento che perviene naturalmente dal bisogno di creare un sistema in grado di funzionare. Comunque, adesso il sistema dovrebbe dare maggiore ascolto ai beneficiari del suo lavoro: alle vittime, ai superstiti ed ai cittadini coinvolti negli incidenti e a tutti le persone che hanno bisogno di aiuto nelle situazioni di crisi. Il servizio dovrebbe essere organizzato dal punto di vista dei loro bisogni, non soltanto per facilitare le organizzazioni ed i sistemi di riferimento del settore.
Questa importante osservazione sottolinea i benefici guadagnati quando si condivide nell'arena internazionale le esperienze della protezione civile. Dobbiamo aumentare e facilitare questa condivisione a tutti i livelli.
In Italia il moderno sistema di protezione civile, eccelente in molti sensi, non è stato ancora messo alla prova da un grande disastro, per fortuna perché chi vorrebbe che avvenisse un evento del genere? Come andrà nel prossimo grande evento? Quali lezioni verranno imparate? Quante lezioni possiamo anticipare ed imparare adesso, tale da non ripetere i soliti errori nel futuro? Sappiamo tutti che preparare per le emergenze non è un processo liscio e lineare. Come nella guerra, ci sono lunghi intervalli di attesa interrotti da brevi periodi di attività frenetica. Ma i periodi di attesa possono essere dedicati alla preparazione, alla formazione e all'addestramento.
In diverse regioni d'Italia si sta creando standard di formazione in materia di protezione civile. In Lombardia, ad esempio, lo Standard regionale per la formazione del personale di emergenza, di larga applicazione, costituisce un passo avanti molto positivo ed è frutto della paziente preparazione "in tempi di pace". Una perizia condotta dall'ANCITEL Lombardia, l'ente di ricerca dell'Associazione dei Comuni, ha rivelato lo svolgimento nella regione di quasi 600 corsi di protezione civile. Mentre un numero così grande rappresenta un segno molto incoraggiante, bisogna imporre un grado di ordine sul contenuto, sulla durata e sulla qualità dei programmi formativi offerti, e questo sarà l'obiettivo dello standard. Mi meraviglia sempre che, mentre la chirurgia al cervello giustamente non può essere praticata da persone prive degli appositi titoli, nel mondo moderno le situazioni di infortunio di massa possono essere gestite da persone senza formazione e sproviste di titoli. Davvero il processo di trasformare la gestione delle emergenze in una professione è lento ed arduo. Essa richiede una costante simbiosi tra il fabbisogno dei corsisti di formazione, i corsi che vengono offerti, i titoli e le qualificazioni che risultano, e il ricognoscimento ufficiale del risultato.
I delegati ad un recente convegno a Roma hanno notato l'esistenza di una spiccata differenza tra "lezioni identificate" e "lezioni imparate". In altre parole, non è sufficiente condurre un debriefing e elencare le cose che hanno bisogno di attenzione prima del prossimo disastro. Ci deve essere un chiaro processo di assorbimento delle lezioni e di svolgimento di azioni in base a ciò che indicano.
E' sorso in questi giorni l'imperativo ad imparare le lezioni di eventi recenti, come l'uragano, Katrina, che ha colpito New Orleans e gli stati del Golfo del Messico alla fine dell'estate 2005. Nello stesso convegno di Roma l'ex-direttore della US Federal Emergency Management Agency (FEMA) ha riflettuto sulle lezioni di Katrina, un evento che l'illustre Professor Quarantelli dell'Università di Delaware ha definito "il peggiore caso di gestione di un'emergenza che ho mai visto in 65 anni di studio dei disastri". A causa di una concentrazione eccessiva sulla preparazione contro il terrorismo, il Governo Federale statunitense ha in effetti "disimparato" le lezioni del disastro naturale. Facciamo in modo che gli stessi errori non vengano commessi in Europa!
Malgrado questo, non bisogna sottostimare l'importanza delle preparazioni per gli oltraggi terroristici. Una vecchia maledizione cinese dice "che tu viva in tempi interessanti". Il filosofo antico fu convinto che una vita priva di eventi sarebbe più felice di una vita affollata di sensazioni assai forti. Intanto, i tempi moderni sono "interessanti" nel senso cinese. In questo momento è chiaro che la geopolitica abbia reso il mondo più pericoloso anziché più sicuro. Come risultato siamo tutti a rischio. Il sito web dello US National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (www.mipt.org) dimostra che gli oltraggi terroristici stanno diventando progressivamente più comuni e più estesi nel mondo. Il sito dimostra anche un'inquietante tendenza del numero di incidenti di crescere. Inoltre, il terrorismo non è soltanto un problema delle aree metropolitane. Dobbiamo affrontare il difficile compito di far sì in modo che la minaccia del terrorismo non sia né esaggerata ne sottostimata, e di fare così a tutti i livelli fino a quello delle unità operative e geografiche più piccole. La stessa cosa è vera rispetto al rischio di una pandemia di aviaria. Una cosa del genere è molto più di una minaccia alla salute: essa potrebbe, ad esempio, causare il colasso dei servizi essenziali a causa dell'assenteismo del personale. Infatti, in Francia l'aviaria viene considerata il pericolo nazionale più grave in assoluto, malgrado i rischi costituiti da eventi meteorologici e idrologici, incidenti nucleari e una larga diffusione di tensioni sociali.
Finora queste riflessioni sono stati un po' troppo nere e minacciose, ma bisogna sempre rendere omaggio al lato positivo. Il sistema italiano di protezione civile può essere ancora da completare (la stessa cosa è vera in tutti i paesi del mondo), ma esso sta vivendo un periodo di rapidissima evoluzione ed è già al punto di poter servire come esempio e ispirazione per il resto dell'Europa: nella mia opinione non esiste un sistema con lineamenti migliori. Recentemente ho avuto il piacere di partecipare nell'inaugurazione del nuovo centro operativo del comune di Signa in Provincia di Firenze. Alla cerimonia sono stato colpito da quanto la protezione civile in Italia è diventata una grande famiglia, con un forte senso di obiettivi condivisi e di mutuo rispetto. In questo momento il paese, e infatti il continente, non si rende conto di quanto abbia bisogno di questa famiglia, ma un giorno sarà consapevole, e molte persone apprezzeranno la sua forza e il senso crescente di preparazione e professionalità. Buon lavoro a tutti i protagonisti della protezione civile italiana!
Quest'anno alcuni studiosi e professionisti hanno fondato un gruppo internazionale intitolato COGSS - Coalition for Global School Safety (Coalizione Globale per la Sicurezza delle Scuole). L'iniziativa parte dal principio che i bambini e i ragazzi abbiano un diritto morale, non soltanto a ricevere un'educazione scolastica, ma ad averla in condizioni di sicurezza. COGSS lotterà per convincere i governi di tutti i paesi del mondo a rispettare questo principio. Il suo sito web, di taglio multinazionale e multilingue, è sotto costruzione a www.interragate.info/cogss/index.html.
L'obiettivo di COGSS è di fornire gli strumenti per approfitare dalle esperienze positive e dai best practice dovunque che si riesca ad identificare qualcosa che vale la pena condividere. Nella protezione civile non seguiamo questa linea quanto potremmo. Ad esempio, uno dei documenti più interessanti e di maggiore rilievo pubblicato durante quest'anno è il rapporto sulle bombe londinesi del 7 luglio 2005 compilato da una commissione di deputati della London Assembly, il "parlamento" della città di Londra (vedi www.london.gov.uk/assembly/reports/general.jsp). Gli autori di questo rapporto non hanno soltanto ricostruito in parole la dinamica di quella tremenda giornata e della risposta di emergenza agli eventi, ma hanno anche raccolto i punti di vista di una larga gamma di esponenti della protezione civile, di vittime e superstiti dei quattro oltraggi terroristici, di londinesi qualunque, e di molti altri soggetti.
Alcune della conclusioni del rapporto sono ben conosciute da tempo, ad esempio sul bisogno di migliorare la cooperazione in situazioni di emergenza tra organizzazioni che normalmente non lavorano insieme, o per lo meno non collaborano nello stesso modo in assenza di una crisi. Altre conclusioni dovrebbero essere ripetute più spesso, ad esempio sul bisogno di rinforzare i canali di comunicazione durante le grandi emergenze. Le reti di telefonia cellulare possono entrare in avaria (a Londra hanno subito raggiunto la saturazione), le frequenze radio potrebbero essere incompatibili, e le radio potrebbero non funzionare in ambienti sotterranei o elevati. Ma la Commissione ha trovato che i più pressanti problemi di comunicazione erano quelli riguardo la presa e la diffusione delle decisioni. E' necessario dare enfasi al fatto che in uno stato di emergenza bisogna dare ordini chiari ed espliciti alle persone giuste al momento giusto, bisogna condividere le decisioni tra le organizzazioni partecipanti, e bisogna informare i protagonisti della protezione civile di che cosa fanno, e che cosa non fanno, gli altri protagonisti delle operazioni di emergenza.
La conclusione più interessante della Commissione dell'Assemblea Londinese è che la protezione civile ha bisogna di uno sostanzioso riorientamento. Finora si è occupato preferenzialmente dell'allestimento e del perfezionamento di organizzazioni, procedure e protocolli, un orientamento che perviene naturalmente dal bisogno di creare un sistema in grado di funzionare. Comunque, adesso il sistema dovrebbe dare maggiore ascolto ai beneficiari del suo lavoro: alle vittime, ai superstiti ed ai cittadini coinvolti negli incidenti e a tutti le persone che hanno bisogno di aiuto nelle situazioni di crisi. Il servizio dovrebbe essere organizzato dal punto di vista dei loro bisogni, non soltanto per facilitare le organizzazioni ed i sistemi di riferimento del settore.
Questa importante osservazione sottolinea i benefici guadagnati quando si condivide nell'arena internazionale le esperienze della protezione civile. Dobbiamo aumentare e facilitare questa condivisione a tutti i livelli.
In Italia il moderno sistema di protezione civile, eccelente in molti sensi, non è stato ancora messo alla prova da un grande disastro, per fortuna perché chi vorrebbe che avvenisse un evento del genere? Come andrà nel prossimo grande evento? Quali lezioni verranno imparate? Quante lezioni possiamo anticipare ed imparare adesso, tale da non ripetere i soliti errori nel futuro? Sappiamo tutti che preparare per le emergenze non è un processo liscio e lineare. Come nella guerra, ci sono lunghi intervalli di attesa interrotti da brevi periodi di attività frenetica. Ma i periodi di attesa possono essere dedicati alla preparazione, alla formazione e all'addestramento.
In diverse regioni d'Italia si sta creando standard di formazione in materia di protezione civile. In Lombardia, ad esempio, lo Standard regionale per la formazione del personale di emergenza, di larga applicazione, costituisce un passo avanti molto positivo ed è frutto della paziente preparazione "in tempi di pace". Una perizia condotta dall'ANCITEL Lombardia, l'ente di ricerca dell'Associazione dei Comuni, ha rivelato lo svolgimento nella regione di quasi 600 corsi di protezione civile. Mentre un numero così grande rappresenta un segno molto incoraggiante, bisogna imporre un grado di ordine sul contenuto, sulla durata e sulla qualità dei programmi formativi offerti, e questo sarà l'obiettivo dello standard. Mi meraviglia sempre che, mentre la chirurgia al cervello giustamente non può essere praticata da persone prive degli appositi titoli, nel mondo moderno le situazioni di infortunio di massa possono essere gestite da persone senza formazione e sproviste di titoli. Davvero il processo di trasformare la gestione delle emergenze in una professione è lento ed arduo. Essa richiede una costante simbiosi tra il fabbisogno dei corsisti di formazione, i corsi che vengono offerti, i titoli e le qualificazioni che risultano, e il ricognoscimento ufficiale del risultato.
I delegati ad un recente convegno a Roma hanno notato l'esistenza di una spiccata differenza tra "lezioni identificate" e "lezioni imparate". In altre parole, non è sufficiente condurre un debriefing e elencare le cose che hanno bisogno di attenzione prima del prossimo disastro. Ci deve essere un chiaro processo di assorbimento delle lezioni e di svolgimento di azioni in base a ciò che indicano.
E' sorso in questi giorni l'imperativo ad imparare le lezioni di eventi recenti, come l'uragano, Katrina, che ha colpito New Orleans e gli stati del Golfo del Messico alla fine dell'estate 2005. Nello stesso convegno di Roma l'ex-direttore della US Federal Emergency Management Agency (FEMA) ha riflettuto sulle lezioni di Katrina, un evento che l'illustre Professor Quarantelli dell'Università di Delaware ha definito "il peggiore caso di gestione di un'emergenza che ho mai visto in 65 anni di studio dei disastri". A causa di una concentrazione eccessiva sulla preparazione contro il terrorismo, il Governo Federale statunitense ha in effetti "disimparato" le lezioni del disastro naturale. Facciamo in modo che gli stessi errori non vengano commessi in Europa!
Malgrado questo, non bisogna sottostimare l'importanza delle preparazioni per gli oltraggi terroristici. Una vecchia maledizione cinese dice "che tu viva in tempi interessanti". Il filosofo antico fu convinto che una vita priva di eventi sarebbe più felice di una vita affollata di sensazioni assai forti. Intanto, i tempi moderni sono "interessanti" nel senso cinese. In questo momento è chiaro che la geopolitica abbia reso il mondo più pericoloso anziché più sicuro. Come risultato siamo tutti a rischio. Il sito web dello US National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (www.mipt.org) dimostra che gli oltraggi terroristici stanno diventando progressivamente più comuni e più estesi nel mondo. Il sito dimostra anche un'inquietante tendenza del numero di incidenti di crescere. Inoltre, il terrorismo non è soltanto un problema delle aree metropolitane. Dobbiamo affrontare il difficile compito di far sì in modo che la minaccia del terrorismo non sia né esaggerata ne sottostimata, e di fare così a tutti i livelli fino a quello delle unità operative e geografiche più piccole. La stessa cosa è vera rispetto al rischio di una pandemia di aviaria. Una cosa del genere è molto più di una minaccia alla salute: essa potrebbe, ad esempio, causare il colasso dei servizi essenziali a causa dell'assenteismo del personale. Infatti, in Francia l'aviaria viene considerata il pericolo nazionale più grave in assoluto, malgrado i rischi costituiti da eventi meteorologici e idrologici, incidenti nucleari e una larga diffusione di tensioni sociali.
Finora queste riflessioni sono stati un po' troppo nere e minacciose, ma bisogna sempre rendere omaggio al lato positivo. Il sistema italiano di protezione civile può essere ancora da completare (la stessa cosa è vera in tutti i paesi del mondo), ma esso sta vivendo un periodo di rapidissima evoluzione ed è già al punto di poter servire come esempio e ispirazione per il resto dell'Europa: nella mia opinione non esiste un sistema con lineamenti migliori. Recentemente ho avuto il piacere di partecipare nell'inaugurazione del nuovo centro operativo del comune di Signa in Provincia di Firenze. Alla cerimonia sono stato colpito da quanto la protezione civile in Italia è diventata una grande famiglia, con un forte senso di obiettivi condivisi e di mutuo rispetto. In questo momento il paese, e infatti il continente, non si rende conto di quanto abbia bisogno di questa famiglia, ma un giorno sarà consapevole, e molte persone apprezzeranno la sua forza e il senso crescente di preparazione e professionalità. Buon lavoro a tutti i protagonisti della protezione civile italiana!